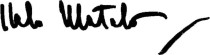Informazioni
Questo sito vuole ricordare l’attività di Italo Mataloni. Troverete una galleria di immagini di alcune tra le sue opere rimaste, e delle recensioni a lui dedicate.
Contatti

“La pittura di oggi:
panoramica e considerazioni”
di Italo Mataloni (01.03.1974)
Confesso un certo disagio perché tradurre in parole colori e forma è forse snaturare all’origine il fondamento su cui poggia la pittura: la percezione di emozioni che vanno dalla retina al cervello.
Come potrebbe nascere più spontaneamente il nostro incontro con la pittura? Forse prendendovi sottobraccio e passeggiando che so, lungomare, in campagna o in una qualsiasi strada cittadina. Potremmo costatare che la natura si presenta ai nostri occhi condizionata dalla pittura. Forse non ce ne accorgiamo ma siamo prigionieri dei valori estetici impostici dall’artista. La vita copia l’arte. Come negarlo?
Ero ragazzo quando, salendo in un tardo pomeriggio da Firenze a Fiesole, mi accorsi di guardare quello splendido paesaggio non com’era ma come l’aveva dipinto Rosai. A Venezia non siamo forse schiavi di Canaletto o di Guardi?
E gli esempi potrebbero continuare a lungo.
Ritengo ora essenziale, prima di entrare nel vivo del tema (tema che sarà da me trattato forzatamente in modo superficiale: esaminare tutte le correnti contemporanee richiederebbe più volumi), ritengo essenziale anziché parlare del pittore, parlare del fruitore.
L’arte non ha senso, se non nasce il dialogo artista-fruitore. Vivono della stessa linfa in quanto l’artista esprime il proprio tempo ed il fruitore ne è il coautore spesso inconsapevole.
Solo che, a valore, il quadro è come uno specchio deformante: non ci si riconosce, forse perché non ci riconosciamo nel nostro intimo.
Mi si dirà che al giorno d’oggi ci sono specchi neri che non riflettono nulla. Ma questo è sempre avvenuto.
Il tempo è un enorme cesto di rifiuti.
Parliamo dunque del fruitore. E riconosciamo subito che essere oggi fruitori di un’opera d’arte non solo non è facile ma è oltremodo scomodo perché i tempi sono scomodi. Si va in fretta, e con la fretta non si giudica né si gusta.
In queste condizioni potremmo prendere dei grossi abbagli ed apprezzare un quadro, che so, solo perché nel nostro fugace incontro con l’opera ci ha colpito un tono più acceso, un’impostazione tradizionale, quindi più facile ad essere recepita.
Il ritmo d’oggi opera indubbiamente a sfavore dell’opera buona, fatta magari di sottili sfumature e di nuove problematiche.
Come dunque giudicare un quadro?
Scriveva Nietzsche: “Niente è più pericoloso di una bella melodia, niente rovina di più il buon gusto”.
Creando il parallelo musica-pittura, questo potrebbe essere il primo avvertimento.
Il bello filtra lentamente. Il tempo, indubbiamente, incidendo nel gusto, ci illumina di comprensione in quanto, nel frattempo, il nostro punto di osservazione ha trovato la giusta collocazione. L’opera rimane ferma, immutabile. Siamo dunque noi che dobbiamo saperla guardare.
Depurati da equivoci, per cui non confondiamo dolcezza con sdolcinatura, verità con verosomiglianza, trasfigurazione con deformazione, possiamo avere quest’incontro con l’opera d’arte ed interrogarla con umiltà ma soprattutto con assiduità. Il velario prima o poi si aprirà.
Sarà inevitabile prendere degli abbagli, succede anche ai più esperti.
Oggi ci sembra strano, addirittura incredibile, che artisti come Michelangelo, Borromini, Caravaggio, cito a caso, Manet, Cezanne, Van Gogh siano stati criticati dai contemporanei, a volte beffeggiati, comunque spesso non compresi.
Certo oggi corriamo – io stesso – rischi per cui, fatti prudenti, spesso ci asteniamo da critiche, dato che domani potremmo rimangiarcele.
Dobbiamo dunque stare zitti in attesa che il tempo lavori per noi? E’ chiaro che anche questo non è possibile. A ciò si rifiuta la nostra intelligenza che comunque vuol intervenire, discutendo, giacché la discussione è la larva di cui si nutre l’arte. E non abbiamo timori nel criticare, pensandolo compito esclusivo degli addetti ai lavori. Accumuliamo in noi solo una buona carica di umiltà giacché, ed è umano, troppe condizioni giocano a favore o a sfavore di un’opera. Sentirsi veramente liberi ed obiettivi nel giudicare un quadro non è nella facoltà neppure del più esperto dei critici.
Sempre, durante il corso dei secoli, gli innovatori hanno avuto vita difficile. Superata la fase di frattura e ormai digerita la nuova forma estetica, finisce la polemica ed il giudizio da avere si fa positivo.
Quando l’artista sente la necessità di creare nuove forme, di aprire un nuovo linguaggio? E’ chiaro, quando uno stile non risponde più ai tempi.
Ed è su una tela, su un pentagramma, su un pezzo di marmo che si rovescia la problematica contemporanea.
D’altronde, nel bene e nel male, tutti coinvolti, dobbiamo considerare l’arte come il frutto della nostra epoca, coi suoi risultati positivi e negativi. L’industrializzazione, la scienza, l’affarismo, i nostri pessimismi, la nostra fragilità sono piani rifrangenti da cui partono le linee, i colori, le strutture, i suoni del nostro tempo.
E’ inevitabile, per una panoramica della pittura d’oggi, percorrere il terreno a ritroso. Ogni nuova visione artistica viene per evoluzione naturale o per reazione alla visione precedente.
Appare così un nome che suggerirà nuovi stimoli a tutta la pittura contemporanea, mi riferisco a Cezanne.
E’ merito dell’impressionismo aver strappato gli artisti dal buio degli studi mandandoli incontro alla natura e alla luce.
La pennellata istintivamente si fece spontanea, pronta alle nuove emozioni suggerite dalla natura che offriva ad ogni mutamento di luce un rapporto, un’impressione diversa.
Fu un periodo meraviglioso. Ma, a lungo andare, questa ebbrezza dello spazio fece dimenticare agli artisti un certo rigore stilistico.
Cezanne sentì imperioso lo stimolo di creare un ordine, un equilibrio, una compostezza compositiva. Dirà, certo non sospettando il peso della sua eredità: “Bisogna ridurre la natura a cilindri, a sfere, a coni”. Ed è proprio sotto queste sollecitazioni che nascerà il cubismo.
L’immediata differenziazione del cubismo rispetto alla visione di Cezanne è quella di rinuncia alla rappresentazione della natura. Ma rimane prigioniero della natura morta. Entra infatti negli oggetti, vi si inserisce. Scopre l’esterno e l’interno delle cose. Introduce l’effetto volumetrico su una superficie piana senza ricorrere al modellato, al chiaroscuro. Decompone l’oggetto, disgregandolo e presentandolo spiegato sul piano della tela.
In questa panoramica sulla pittura d’oggi abbiamo dovuto citare il cubismo perché una figura incombe preminente, egemonica, discussa, esaltata (anche se le nuovissime leve non guardano più a lui come al suggeritore d’obbligo). Intendo riferirmi naturalmente a Picasso.
La polemica picassiana si presta ad esaltazioni eccessive come a condanne ingiustificate. Forse (azzardo un’ipotesi) se il mercato convulso, esagitato e la presunzione di molti esegeti avessero lasciato più spazio alla penetrazione naturale di un evento artistico (come è sempre avvenuto nel passato) forse tante incomprensioni od esaltazioni non avrebbero avuto luogo.
Ma Picasso è figlio del suo tempo ed il tempo, purtroppo, è oggi vincolato ad un mercato sempre più consumistico. La figura del mercato condiziona indubbiamente il gusto e le tendenze.
E approfitteremo proprio di Picasso per esaminare a volo d’uccello i vari momenti pittorici che l’artista ha preso in esame o rielaborato.
Il surrealismo, nato dalla metafisica di De Chirico (uno dei nomi italiani più prestigiosi) tratta un tema di per sé suggestivo, penetra cioè nei misteri dell’inconscio. L’accostamento inatteso di elementi senza rapporto fra loro, provoca la sollecitazione dei sogni e delle angosce.
L’oggetto si libera del suo significato convenzionale suggerendo, complice il ricorso psicologico, una nuova rappresentazione.
Così sviluppano la loro tematica, variata da sottili, personali riflessioni, i surrealisti Magritte, Dalì, fino a Mirò che entra nel mondo fantastico e libero dell’infanzia.
Ma Picasso è presto inappagato dei problemi metafisici letterali del surrealismo.
La guerra civile di Spagna gli suggerisce e lo fa interprete drammatico di un’altra corrente stilistica: l’espressionismo.
Nasce così Guernica.
Dobbiamo risalire a Van Gogh per poter indicare il promotore dell’espressionismo. Ad un artista cioè che negli ultimi anni della sua vita, rovescia sulla tela con un segno drammatico, convulso, tormentato, tutta la propria sofferenza.
La malinconia, la solitudine dolorosa saranno gli stati d’animo di Munch. La satira sociale ed il risvolto doloroso della guerra suggeriranno gli spunti a Crosz.
Picasso ritrova presto fermenti classici, poi realistici, infine astratti.
Siamo dunque all’astrattismo.
Dal 1910, dalla sua nascita cioè, ad oggi, è fonte di discussioni.
Ma indaghiamo innanzitutto come nasce:
Le due arti, musica e architettura, sembrano atte a stimolare la consorella pittura. Uno dei motivi validi per cui è nato il concetto informale è stato il desiderio di rompere con schemi che, legati alla forma, erano sentiti come una prigione negante libertà e spontaneità all’artista. Si spazza quindi ogni riferimento con la realtà.
Infatti Kandisky scriveva nel 1910: “Seppi allora che gli oggetti nuocevano alla mia pittura”.
In Mondrian il rapporto architettonico, teso all’essenziale: due linee rette che si intersecano. Il rapporto verticale-orizzontale sarà il tema fisso di tutta la sua vita. E se le campiture saranno inizialmente grigie poi azzurre in seguito, quasi a testimonianza di un’essenzialità assoluta, i fondi saranno sempre uniformemente bianchi.
Mondrian influirà prepotentemente sulla pittura contemporanea. In seguito ed ancor oggi si ripeteranno fino alla stanchezza i temi da lui suggeriti con spontaneità.
E giungiamo ad Afro che aggredisce la tela facendola vibrare di gialli, di rossi, di arancioni, senza intervalli perché il quadro nasce e finisce nello spazio in cui vive l’emozione.
Con Emilio Vedova il ritmo è dinamico, le sconvolgenti pennellate dal suggerimento espressionista sono costruite quasi esclusivamente in bianco-nero, quasi ad evidenziare l’essenzialità ritmica.
Arte figurativa, arte astratta. Le acque si placano e sta tramontando finalmente, almeno lo spero, la diatriba sul conflitto astratto-figurativo. Diatriba nata da un malinteso. Spesso ho sentito dire, e soprattutto da pittori dilettanti: “Io sono astrattista dato che ho superato il concetto figurativo”. A parte il fatto che il dilettante (e lascio intatte le prerogative positive del dilettantismo) non può aver potuto superare un bel nulla, esiste per alcuni l’errato e comodo presupposto che l’arte astratta sia concettualmente a livello più alto rispetto all’arte figurativa. Arte l’una, arte l’altra quando, sia chiaro, esistano i presupposti, le tecniche e le forze spirituali perché lo siano.
Ma, dicevo, questa discussione sta placandosi anche perché sull’informale è arrivato il momento di fare il punto. E quando si fa il punto spesso si cambia pagina. Ci si accorge ad esempio che motivi astratti sbandierati per nuovi non sono che stantie ripetizioni di tentativi già fatti sessant’anni fa. Niente di più frustro di un’idea rimasticata, soprattutto in un campo in cui la molla vitale è proprio l’idea, spesso (se meglio vogliamo definirla) la trovata. Ripescarla vuol dire mettere nell’amo un pesce morto.
Ma riprendiamo il filo. Si cercano nuovi materiali atti a suggerire uno stato d’animo, l’interpretazione di una distruzione morale.
E’ il caso di Alberto Burri che si serviva dei materiali più umili, dei sacchi sfilaiati la cui trama logora esprimerà lo sfacelo, il consumarsi delle nostre risorse.
Per Lucio Fontana la condizione umana è sentita come un vincolo che limita le ricerche e le aspirazioni. Guarda allo spazio come ad una liberazione dei dogmi terrestri. I suoi <concetti spaziali> ottenuti prima con fori, quasi a suggerire il vorticoso muoversi degli atomi, poi con tagli praticati sulla tela o sull’alluminio, rientrano in una espressione gestuale che, avvalendosi appunto del gesto dinamico, istintivo, taglia la materia con intenti carichi di espressività.
Possiamo considerarla, insieme ad altre tematiche, una proposta: ma nel frattempo e già dal 1915 si era passati alla provocazione con opere dadaiste che volevano agire sul costume. La delusione cocente per la sistematica distruzione (complice la guerra) di valori umani e spirituali da sempre inneggiati e da sempre in realtà calpestati, provocano nei dadaisti, come reazione ad un mondo corrotto, questa sfida protestataria che si manifesta con l’irrisione, con la provocazione, con l’ironia.
Potremmo citare Duchamp come uno dei maggiori interpreti del dadaismo.
Rettificando una realtà (il riferimento è sempre indirizzato verso oggetti che si incontrano nella vita) la sviluppa in chiave polemica. Ad esempio: la “Fontana orinatoio” o in chiave ironica, quale a riproduzione della “Gioconda con baffi”.
Nel 1947 espone il “Seno rosato in gomma piuma con preghiera di toccare”. Da allora i problemi sociali sono rimasti pressoché inalterati; ma l’artista ha il dovere di suggerire nuovi, sinceri stimoli. Da allora che si è detto di diverso? Solo rimanipolazioni di queste idee. Annullata la vitalità della trovata credo non rimanga che un deserto desolante.
Lo stesso Duchamp, aborrendo di ripetersi, cessò di produrre.
Che lo si accetti o no, ammiriamone la buona fede.
E siamo all’ultima Quadriennale:
L’artista invita il pubblico ad intervenire nella sua opera. Ci imbattiamo in uno spazio recintato con frecce d’andata e ritorno: dobbiamo percorrerlo avanti e indietro secondo il suggerimento dell’artista, diventando, si fa per dire, complici della sua opera.
De Dominicis ci invita a gettare un sasso in una vasca. Si potranno ottenere, per assurdo è ovvio, movimenti quadrati anziché circolari. Ma passiamo oltre.
Nel frattempo, nel panorama artistico è ricomparso l’uomo. Forse ne ritroviamo i brandelli ma è naturale sia così. Quest’uomo condannato al servilismo di sé stesso, vittima e prigioniero della propria frenesia economica e dell’incomunicabilità. L’artista fa il ritratto della propria desolazione. Siamo al superrealismo, angosciosa immagine dell’uomo prigioniero di un cubo.
Ne sono promotori gli italiani Vespignani, Vangi, Sughi ed altri.
Esiste un altro aspetto della realtà, quella americana: in questo caso l’uomo contemporaneo ha sentito la propria impotenza, la propria nullità, tutto il grigiore e l’anonimato della propria esistenza. Siamo al convenzionatismo spersonalizzato dell’iperrealismo americano.
Ma un incontro con l’uomo in fase politico-sociale si manifesta in diversi artisti fra cui Guttuso cui erge una realtà da evidenziare.
Dopo la proliferazione degli “ismi” e le tematiche concettuali, la corrente naif spunta nel periodo giusto. Il carattere di sincerità, la poesia dell’infanzia rivissuta, le ingenuità (però non più espresse successivamente in forma genuina, fatto purtroppo inevitabile quando si crea un mercato) offrono allo spettatore un alito di freschezza. Esiste un altro motivo valido a spiegarne il successo. A livello di galleria qualificata il paesaggio era uscito dal panorama della pittura contemporanea. Vi rientra di prepotenza coi naifs.
E cito l’ultima esibizione artistica che ha avuto per testimoni i milanesi e in questi giorni i romani.
Pochi giorni fa il bulgaro Christo, circondato da una ben nutrita schiera di fotografi, cineoperatori, ingegneri, tecnici, operai, avvocati (non si sa mai) ha impacchettato le mura Aureliane.
A dispregio naturalmente dell’archeologia del passato, dell’immutabile.
E se nel futuro ci ritrovassimo tutti avvolti in un’immane, immenso manto di plastica? E sappiamo che la plastica non lascia respirare.
Ma non voglio terminare con una nota patetica. Nonostante tutto cerchiamo di essere ottimisti.
Ogni racconto suggerisce una morale. L’arte di questa fiaba per adulti farà trionfare, come in tutte le fiabe, il bene sul male?
Che cos’è un quadro in definitiva se non una pagina scritta?
Abbiamo già detto che siamo noi che dobbiamo saperla leggere, ma soprattutto siamo noi a dover suggerire all’artista una visione più morale dei tempi che viviamo.